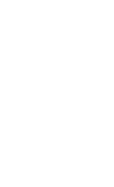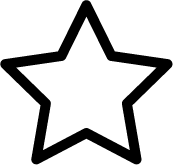26 marzo 2018
La retorica delle parole ostili e il volano dell’intolleranza verso gli intolleranti. A commento di una recente decisione dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
di Marco Bassini
Il messaggio consistente nell’associazione tra la dicitura “Basta violenza di genere – I bambini sono maschi. Le bambine sono femmine” e la rappresentazione grafica di due mani che offrono a una sagoma infantile di colore rosa un paio di baffi e a una sagoma infantile di colore azzurro un reggiseno non viola gli artt. 10, 11 e 46 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Il messaggio non determina alcuna violazione della dignità della persona e non integra una discriminazione fondata sul genere: in presenza di un appello al pubblico che, pur presentando alcuni elementi di ambiguità, è privo di un contenuto offensivo e discriminatorio, deve infatti prevalere il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.
Parimenti, il messaggio non contiene elementi dannosi per i minori che lo osservano, potendo essere, quanto alla componente testuale, in parte per loro incomprensibile e in parte percepibile come un’affermazione generica; e, quanto alla parte grafica, inidoneo a suscitare forte impressioni.
Altresì, il messaggio si presenta quale manifestazione di un’organizzazione di tendenza e non come informazione di carattere imparziale, sicché non sussiste alcun pericolo che esso sia inteso dall’osservatore come espressione di fatti accertati anziché come espressione di opinioni di parte.
1. Introduzione
La Manif Pour Tous e Citizen GO sono due associazioni attive in diversi paesi che perseguono l’obiettivo di contrastare la diffusione di teorie educative che, parallelamente all’approvazione di leggi contro l’omofobia e la transfobia e a favore di unioni e adozioni tra coppie omosessuali, tenderebbero alla decostruzione della famiglia naturale e alla rivisitazione dell’identità sessuale, con importanti ripercussioni sul versante della libertà di manifestazione del pensiero. Tali associazioni contestano, così, la cosiddetta “teoria del gender”, che si appellerebbe a una svalutazione delle differenze tra i generi dell’identità sessuale per giustificare la legittimità delle unioni omosessuali. È noto che il riferimento a tale ideologia presenta una corrispondenza semantica piuttosto ambigua che, in carenza di precise indicazioni scientifiche, sembra talora prestarsi a un utilizzo retorico e perfino strumentale. Se non è agevole identificare le fondamenta scientifiche ed epistemologiche di questa teoria, sono nondimeno ben chiare le derive relativistiche contro cui si schierano le attività delle associazioni La Manif Pour Tous e Citizen GO.
È in questo contesto che si colloca la vicenda che ha dato origine alla pronuncia in commento, scaturita da una campagna informativa avviata dalle due associazioni nello scorso autunno e organizzata nella forma di un tour tra le piazze di varie città italiane del cosiddetto “bus della libertà”. Il tour nelle piazze veniva preannunciato da cartelloni stradali che recavano alcuni messaggi uniti a rappresentazioni grafiche, che campeggiavano sullo stesso autobus di colore arancione utilizzato dagli organizzatori della campagna informativa. Tali messaggi consistevano nella dicitura “Basta violenza di genere”, accompagnata dalla rappresentazione grafica di due mani che offrivano a una sagoma infantile di colore rosa un paio di baffi e a una sagoma infantile di colore azzurro un reggiseno, sotto la quale erano collocate le espressioni “I bambini sono maschi” in azzurro e “Le bambine sono femmine” in rosa. A corredo di queste indicazioni, il messaggio includeva la sagoma stilizzata del bus arancione e l’indicazione dei siti Internet delle associazioni promotrici.
2. L’ingiunzione di desistenza
Con provvedimento del 4 ottobre 2017, il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, ingiungeva alle due associazioni di desistere dalla diffusione, con ogni mezzo, del suddetto messaggio. Si scoprirà poi che l’ingiunzione di desistenza era stata adottata all’esito di una segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui, in base al Protocollo di intesa in essere con l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, venivano trasmessi alcuni esposti ricevuti da privati.
L’ingiunzione, adottata ai sensi dell’art. 39 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria (di seguito, anche il “Codice”), si fondava sull’accertata violazione di tre distinte disposizioni, segnatamente l’art. 10 (rubricato “Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona”), l’art. 11 (“Bambini e adolescenti”) e l’art. 46 (“Appelli al pubblico”). A determinare la lesione di queste prescrizioni, ad avviso del Comitato di Controllo, erano soprattutto tre caratteristiche: la perentorietà delle espressioni e delle immagini utilizzate, giudicata idonea a offendere la dignità della persona e in particolar modo di «coloro che non si riconoscono nell’impostazione rigidamente escludente assunta dai promotori»; la capacità di turbamento della sensibilità dei minori mediante una prospettazione asseritamente rigida dell’identità sessuale, in grado di impattare su «condizioni personali molto delicate e anche dolorose»; l’assenza di indicazioni che consentissero di precisare che quella veicolata fosse in realtà un’opinione di parte, da accogliersi «nel rispetto delle sensibilità diffuse».
Le associazioni promotrici presentavano opposizione all’ingiunzione, negando la sussistenza di una violazione delle norme del Codice a fronte di un messaggio che si sarebbe limitato a presentare un’opinione su un tema di cogente attualità indicando chiaramente la propria provenienza. Tale opinione, ad avviso degli opponenti, avrebbe reagito, nel pieno esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, «a un tentativo preponente (i.e. violento) di imposizione culturale […] avente quali destinatari finali bambini e adolescenti e finalizzato ad obliare il dato dell’identità sessuale come qualificazione obiettiva e biologica», la cosiddetta ideologia gender ormai di carattere mainstream.
Il Comitato di Controllo rigettava l’opposizione, precisando i propri dubbi sulle modalità di estrinsecazione del messaggio, tali da configurarlo come un fatto accertato e non come un’opinione, alla stregua cioè di un paradigma assoluto noncurante dell’esistenza di sensibilità diverse che avrebbe evocato l’esistenza di una violenza di genere in relazione a ogni costruzione aliena dalle categorie predefinite dell’identità sessuale.
Gli atti venivano quindi trasmessi al Presidente del Giurì, innanzi al quale il Comitato di Controllo rinnovava la richiesta di rigetto dell’opposizione e le associazioni ingiunte presentavano una memoria di replica.
Tale memoria ribadiva l’insussistenza delle violazioni contestate dal Comitato di Controllo, esponendo che l’espressione “violenza di genere” dovesse precipuamente intendersi come riferibile a «qualsiasi atto di indebita ingerenza nel processo personale di maturazione e di estrinsecazione dell’identità sessuale»; e che il messaggio non presentasse alcun contenuto escludente, dovendosi interpretare, più correttamente, come invito a desistere da forme di condizionamento precoce dei bambini sul tema dell’identità sessuale. Proprio la funzione del messaggio giustificava, ad avviso delle associazioni promotrici, l’utilizzo di un linguaggio forte e suggestivo.
3. La decisione del Giurì
Con decisione del 10 novembre 2017, il Giurì ha dichiarato che la comunicazione contestata non fosse in contrasto con alcuna disposizione del Codice.
Il provvedimento ha esaminato separatamente le presunte violazioni che avevano motivato l’ingiunzione di desistenza.
Dapprima, e più estensivamente, il Giurì ha preso in considerazione la violazione dell’art. 10, comma 2 del Codice, a mente del quale la comunicazione commerciale «deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere».
La pronuncia muove da una ricognizione delle diverse interpretazioni offerte, rispettivamente, dal Comitato e dalle due associazioni al messaggio controverso.
Da un lato, gli opponenti sostengono l’esigenza di contestualizzare il messaggio, collocandolo nell’ambito del dibattito occasionato da iniziative in ambito scolastico volte a «propagandare l’idea della “fluidità” di genere e del carattere puramente opzionale dell’identità sessuale dell’individuo». Tali iniziative turberebbero il normale percorso di costruzione dell’identità sessuale, costituendo forme di intrusione prepotente e dannosa nella psiche dei minori. Sicché, in questo quadro, l’utilizzo dell’espressione “violenza di genere” troverebbe piena giustificazione semantica.
Dall’altro lato, il Comitato di Controllo sottolinea invece l’intrinseca ambiguità del significato lessicale del messaggio, in quanto l’espressione “violenza di genere” conoscerebbe, nel sentire comune, una particolare declinazione, legata alla violenza contro le donne. Talché la percezione per l’osservatore medio risulterebbe disorientante e il messaggio rischierebbe di essere inteso come denuncia del carattere violento di «qualsiasi pratica e […] qualsiasi opinione che metta in dubbio la dicotomia rigida ricevuta dalla tradizione, in materia di identità sessuale». Questa lettura motiverebbe la lesione della dignità della persona e il carattere discriminatorio del messaggio.
Il Giurì, al riguardo, ha preso le distanze da entrambe le interpretazioni prospettate, rilevando come l’attenzione dell’osservatore medio sarebbe invero catturata in particolar modo delle parole “basta violenza” e dall’immagine delle mani incombenti sulle sagome di due bambini, che costituiscono così, in una valutazione sintetica, «il nucleo centrale» del messaggio. Al contrario, le parole “di genere”, riportate nel rigo sottostante l’espressione “basta violenza”, potrebbero essere intese nel senso prospettato dagli opponenti solo dagli osservatori più informati, mentre ad altri, specie a coloro che riferiscono abitualmente tale espressione alla violenza sulle donne, susciteranno maggiore incertezza, anche in considerazione del significato complessivo del manifesto pubblicitario: ma non rivestono la medesima centralità della locuzione “basta violenza” e della rappresentazione grafica corredata.
Secondo il Giurì, pertanto, il messaggio può essere senz’altro percepito dall’osservatore medio come «una reazione fortemente polemica avverso iniziative “violente”», tese a incidere sulla formazione dell’identità di genere nei minori; ma lo stesso non può costituire «una condanna morale di qualsiasi opinione che […] proponga scelte pedagogiche differenti da quelle tradizionali, e tanto meno come un messaggio volto ad offendere e discriminare le persone sulla base dell’identità di genere».
Il messaggio si deve dunque interpretare come «una reazione difensiva contro iniziative altrui che, a torto o a ragione, appaiono caratterizzate da modalità “violente”, e non come una demonizzazione di qualsiasi opinione non tradizionalista in materia di identità di genere». Secondo il Giurì, nonostante persistano elementi di ambiguità, questi ultimi non sono sufficienti, nella fattispecie, a dare luogo a una violazione; la quale sarebbe integrata soltanto ove si dimostrasse che le espressioni contenute nel messaggio fossero decodificate dagli osservatori come offensive delle dignità della persona o discriminatorie. Pertanto, «in presenza di un appello al pubblico, che pur presenta qualche elemento di ambiguità, ma che non ha un chiaro contenuto offensivo o discriminatorio, deve prevalere il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero».
Così esclusa la violazione dell’art. 10, relativo a convinzioni morali, civili, religiose e alla dignità della persona, la decisione del Giurì si è appuntata, sinteticamente, anche sugli ulteriori profili al centro dell’ingiunzione.
Dapprima, la pronuncia ha escluso una violazione dell’art. 11 (Bambini e adolescenti): il messaggio non contiene alcun elemento in grado di nuocere psichicamente ai bambini che dovessero osservarlo, essendo l’espressione utilizzata loro incomprensibile o comprensibile soltanto come affermazione generica e la rappresentazione grafica inidonea a suscitare forti impressioni o turbamento.
In secondo luogo, il Giurì ha ritenuto parimenti insussistente la lesione dell’art. 46, relativo agli appelli al pubblico. Tale norma impone che, ferma la libertà di esprimere le proprie opinioni, dal messaggio deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni e non di fatti accertati. Il messaggio in questione, secondo il Giurì, si configura senz’altro come espressione di associazioni di tendenza, che non sono portatrici di un’informazione imparziale. Si tratta, infatti, di un messaggio “firmato”, chiaramente loro riconducibile, e dunque inidoneo a ingenerare nell’osservatore l’impressione che si verta su fatti accertati.
4. Qualche breve osservazione a margine
La vicenda descritta nei paragrafi che precedono si presta senz’altro ad alcune interessanti, ancorché succinte, riflessioni.
Per comprendere appieno la portata e l’impatto della ingiunzione di desistenza del Comitato di Controllo e della successiva decisione del Giurì non è inutile rammentare come l’obiettivo del Codice di Autodisciplina sia quello di assicurare che la comunicazione commerciale, come recita l’art. 1, «venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore». E ancora: sempre a norma dell’art. 1, il Codice definisce le attività che sono in contrasto con tali finalità, ancorché le stesse siano conformi alle vigenti disposizioni legislative: si tratta di un passaggio di non poco momento.
Esaurite queste precisazioni preliminari, è però indubbio che la decisione restituisca indicazioni non trascurabili sul piano della libertà di manifestazione del pensiero e dei suoi possibili limiti e specialmente su quello della politica del diritto, in un’epoca contrassegnata da divisioni talvolta esacerbanti originate dall’uso di un lessico effettivo o presunto discriminatorio che si ricollega anche a tematiche relative all’appartenenza di genere e di identità sessuale.
Occorre in prima battuta interrogarsi su quale spazio occupi una comunicazione come quella controversa nella vicenda in commento, che evoca un contrasto alla “violenza di genere” facendosi portatrice di un motto (“i bambini sono maschi. Le bambine sono femmine”) non opinabile nella sua incontestabile verità fattuale. Si versa in un campo, quello della comunicazione sociale, che senz’altro non può ricondursi pedissequamente all’ambito del commercial speech ma che nemmeno probabilmente attinge il perimetro del political speech, tradizionalmente più sensibile nell’interpretazione data dalla giurisprudenza delle corti (su tutte, la Corte europea dei diritti dell’uomo). Non è inutile ricordare lo standard di tutela modellato dalla Corte di Strasburgo nel famoso caso Handyside, in base al quale anche le espressioni che possono offendere o scioccare partecipano della tutela prevista dall’art. 10 CEDU: non soltanto, cioè, le informazioni che sono accolte in modo favorevole o con indifferenza ma anche quelle che possono suscitare inevitabili sentimenti di riprovazione beneficiano dell’arco di protezione tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Diversamente, infatti, non sarebbe rispettato uno dei criteri che informa ogni possibile limitazione della libertà di parola, ossia la stretta necessità nell’ambito di una società democratica. Se questo è il tracciato entro il quale la libertà di manifestazione del pensiero è salvaguardata, occorre interrogarsi su quale spazio possano occupare espressioni che, pur celando l’uso di una provocazione e facendo appello al potere di suggestione delle parole, presentano un messaggio formalmente e sostanzialmente corretto e veritiero.
Questo standard di protezione della libertà di parola sembra aver ceduto il terreno, più di recente, a una pericolosa retorica della parole ostili, che sovraccarica l’uso del linguaggio meno polite di una portata superiore ai suoi reali confini offensivi, al punto talvolta da invocare addirittura reazioni dell’ordinamento giuridico, finanche in sede penale. L’intolleranza verso gli intolleranti o, volendo meglio parafrasare Popper, la riprovazione delle parole riprovevoli sembra così anticipata a una soglia di molto inferiore rispetto a quella in cui sarebbe effettivamente necessaria per salvaguardare la funzionalità del sistema democratico (a ben vedere, per i giuristi, non si tratta d’altro che di una applicazione più rigorosa del criterio di stretta proporzionalità). Tale deriva appare preoccupante soprattutto in un’epoca dominata da un moltitudine di dibattiti sul contrasto ai fenomeni delle fake news e dell’hate speech, in cui non esita a manifestarsi una tendenza ad apprezzare la bontà di giudizi e le opinioni, per loro natura personali e soggettivi, parametrandoli a una verità sublimata, mainstream, dunque surrettizia e soltanto pretesa ma indelebilmente soggettiva.
Il caso in commento non appare in questo senso isolato, se si considerano alcuni episodi, quasi paradossali, tratti dall’attualità che pure esulano dall’ambito specifico della comunicazione commerciale.
Di questa inclinazione si fa testimone, per esempio, la bizzarra e grottesca invettiva di un appassionato (e forse miope) tifoso di una squadra di calcio di Serie A che, contestando a un ex arbitro e opinionista sportivo la ricostruzione (peraltro impeccabile) della segnatura di un gol dichiarato in fuorigioco, paventava di effettuare una segnalazione alla Polizia di Stato, in base ai nuovi strumenti di repressione delle fake news introdotti dal Ministero dell’Interno. O ancora, di analoga deriva sembra rivelatrice anche l’infelice sortita di Lucia Annibali nei confronti di Marco Travaglio, accusato di aver auspicato, pur con parole forti ma semanticamente non opinabili e chiaramente metaforiche, lo “scioglimento nell’acido” della legislatura, a suo avviso poco commendevole, che va chiudendosi.
Il rischio è che, anziché tenere le porte aperte a uno spazio di dissenso che sarebbe conforme all’idea di un libero mercato delle idee, si accrediti la tendenza a catalogare come “fake” o come oltraggioso , a seconda dei casi, tutto ciò che non risponde a una sensibilità dominante (non necessariamente la più “corretta”), con annessa soccombenza delle opinioni di avviso contrario (non necessariamente “sbagliate”). E che ogni valutazione sulla forma finisca per imporsi anche come giudizio sulla sostanza delle parole (col che, naturalmente, non si vuole negare l’insopprimibile rispetto del criterio di continenza delle parole: che però pare altra cosa rispetto ai temi in questione nelle vicende che si commentano).
Si eliminerebbe, così, quella zona grigia, quel diritto talvolta all’irriverenza, talvolta al linguaggio mordace e finanche salace, talvolta al politicamente scorretto che è il sale della libertà di manifestazione del pensiero. Finendo per tradire così lo spirito di tolleranza che si cela dietro la garanzia ampia del diritto a esternare il proprio pensiero.
Se queste preoccupazioni appaiono fondate, bene ha fatto allora il Giurì a cassare l’ordine di desistenza del Comitato di Controllo, rimuovendo un precedente che sarebbe senz’altro divenuto un pericoloso macigno. Il tutto a tacere dei profili più strettamente giuridici; a rigore dei quali, volendo, il messaggio, condivisibile o meno, veicolato dalle organizzazioni reclamanti era chiaramente percepibile come provocatorio e in aperta polemica, dove l’espressione, pur suggestiva, “violenza di genere” poteva del resto ben essere contestualizzata alla luce della successiva locuzione “i bambini sono maschi. Le bambine sono femmine”, e dove era ben indicata la provenienza del messaggio da associazioni di tendenza, circostanza da permettere a chiunque di percepire la portata non escludente e “parziale” dello stesso. Un elemento, quest’ultimo, a voler quasi ricordare l’importanza di una libertà che l’ordinamento tutela specie ove esercitata “a volto scoperto”: dove quel volto scoperto serve, appunto, proprio a promuovere un dibattito sulla sostanza delle parole, non arrestandosi alle asperità della forma.
Fonte: Media Laws